Una scoperta di Giovanni Rimondini (un passo del romanzo col richiamo a una data) ha scatenato Moreno Neri. Che cosa lega lo scrittore russo al Signore di Rimini? Seguite questo viaggio, fra certezze e indizi, spirito e carne, cinema e letteratura. E il nobile Tempio riempito di opere pagane...
Una sua simile l’aveva preceduta? Ah sì, certo che sì! E in verità non ci sarebbe stata forse nessuna Lolita se un’estate, in un principato sul mare, io non avessi amato una certa iniziale fanciulla. Oh, quando? Tanti anni prima della nascita di Lolita quanti erano quelli che avevo io quell’estate.
Potete sempre contare su un assassino per una prosa ornata. Signori della giuria, il reperto numero uno è ciò che invidiarono i serafini, i male informati, ingenui serafini dalle nobili ali.
(Vladimir Nabokov, Lolita, dall’incipit, 1955)
Questo articolo non sarebbe mai nato senza l’iniziale suggerimento di Giovanni Rimondini, indicazione circoscritta nella sua profonda conoscenza dell’epoca malatestiana, e senza il suo impagabile colpo d’occhio nel confronto tra moderno e antico. A lui vanno i miei più calorosi ringraziamenti e gli dovrebbe in generale essere grata la città di Rimini con ancor maggiore applicazione di quanto è possibile alla mia dimessa persona.
Avendo soddisfatto, come si confà a uno studioso di classe, il parodico obbligo indicato da Eco secondo il quale «una ricerca senza debiti è sospetta e qualcuno va sempre e in qualche modo ringraziato», questa cartolina è consacrata a Lolita di Nabokov.
Anche chi non ha letto il romanzo di Vladimir Nabokov (1899-1977), avrà forse visto il film, con James Mason e Sue Lyon, che Stanley Kubrick gli dedicò nel 1962 o quello del 1997, diretto da Adrian Lyne, con Jeremy Irons e Dominique Swain. A me sono accadute tutte e tre le cose, ma immagino che tutti ne conoscano il soggetto, almeno a grandi linee. Se non è così, siete un semplicione da sanare oltre che da studiare.
Ho ancora, in uno dei miei numerosi e carichi scaffali, la vetusta edizione Oscar del 1966, una delle mie letture di formazione. Confesso di aver passato la mia prima umida adolescenza a leggere libri del genere (detto con chiarezza: con elementi di erotismo) con la freschezza di vivere il privilegio della letteratura al modo in cui, immaginavo, avrei vissuto la vita reale in giorni indimenticabili. Eppure non mi è mai accaduto di provare il sommo piacere di incontrare una Lolita o di innamorarmi di una ninfetta. Non frequentando case d’appuntamenti, non avrei all’età di 49 anni neppure incontrato una amabile Laide come Dino Buzzati in Un amore. All’inverso, non ho incontrato a 18 anni neanche una Mrs. Robinson. Quello che in quell’età elementare ci attrae è l’aprirsi delle porte alla possibilità, all’immaginazione altrui srotolata davanti a sé. Non ho nessun pizzicore agli occhi e neppure in altre parti per non aver vissuto momenti simili, nessun rimpianto per storie d’amore o, più materialmente, di sesso mai consumate. Ogni vita, se piena, ha una forma e un orizzonte, una sua realizzazione, una sua realtà fatta di qualcosa di altrettanto struggente, altrettanto ridente, altrettanto tragico, altrettanto formidabile, altrettanto completo, altrettanto non ricambiato, altrettanto contraccambiato, altrettanto… metti tu, lettore, l’aggettivo che preferisci.
Humbert Humbert è un professore di letteratura trentasettenne e il romanzo è il suo racconto in prima persona o meglio una confessione chiara e sincera al doppio pubblico del tribunale e dei lettori della sua fatale estate del 1947.
La scoperta di Giovanni Rimondini è questo dettaglio, un passo del romanzo, con il richiamo a una data, i cui livelli e significati mi ha, con il tatto di non dirmelo, esortato ad indagare e intersecare. Si trova nella parte in cui Humbert Humbert contempla la possibilità di uccidere Charlotte, la vedova che ha accettato di sposare per restare accanto alla sua figlia dodicenne: «Se fossimo stati nel 1447, invece che nel 1947, avrei forse potuto circuire la mia indole mite somministrando a Charlotte qualche classico veleno da un’agata cava, qualche tenero filtro di morte. Ma nella nostra era borghese e impicciona non l’avrei fatta franca come tra i broccati dei palazzi d’una volta».
Da dove viene questo rimando nabokoviano fra il suo presente e cinquecento anni prima? L’impiego della polvere di arsenico nascosto in una gemma cava di un anello fa parte della leggenda nera di Lucrezia Borgia. Meno familiare, con l’eccezione di alcuni lettori riminesi, è la figura dell’uxoricida che la passa liscia. «Una donna aveva saputo incantarlo, alla quale egli sacrificò tutte le altre; – scriveva il romantico Yriarte nel 1882 di Sigismondo Pandolfo Malatesta – egli non doveva arretrare né di fronte al veleno né di fronte all’assassinio per appartenerle tutt’intero».
Sulle vicende matrimoniali di Sigismondo, in un’epoca e in un ambiente come quello delle corti in cui i matrimoni erano alleanze politiche, matrimoni di Stato, per secoli aleggiò un alone sulfureo, maleodorante di corruzione morale.
Rotto nel 1432 il fidanzamento avvenuto al principio dell’anno con la figlia di Francesco Bussone, conte di Carmagnola, dopo che questi fu condannato a morte dalla Repubblica di Venezia per tradimento, fino a tutto l’Ottocento si raccontava che la figlia dello sfortunato condottiero fosse stata fatta morire da Sigismondo e che avesse bestialmente ucciso anche le due successive mogli, la prima avvelenata, la seconda strangolata.
Nel 1433 sposa la figlia Ginevra del marchese di Ferrara Niccolò d’Este. Si spense a Rimini l’8 settembre 1440 ad appena ventidue anni. I pettegolezzi che si levarono contro il signore di Rimini sarebbero divenuti uno dei capi d’accusa del processo di scomunica istruito dal papa Pio II. L’anno dopo, il 25 ottobre, Sigismondo contrae una nuova alleanza attraverso il matrimonio con Polissena Sforza, figlia di Francesco Sforza, duca di Milano. La seconda moglie di Sigismondo muore il 1° giugno 1450 e lo storico riminese Clementini arriva persino a indicare lo strumento del delitto di Sigismondo: «un asciugatoio (una salvietta, ndr) avvoltole strettamente al collo». Anche per questo secondo caso Enea Silvio Piccolomini, il papa Pio II, nei suoi Commentarii è esplicito nella sua accusa. Si è dimostrato, al vaglio della storiografia contemporanea, molto più benevola, che sono tutte accuse prive di peso, vibrate dal pontefice senese per tratteggiare uno specialissimo ritratto morale di Sigismondo, un concentrato di nequizie d’ogni genere e natura: lussurioso, assassino, adultero all’eccesso, superiore in crudeltà a un barbaro, falso, spergiuro, «vergogna d’Italia e infamia della nostra generazione».
Sposo sanguinario o no, Sigismondo ci interessa qui, in relazione a Nabokov, come l’uomo che divinizza la sua amante, e poi moglie, Isotta. La conosce nell’estate del 1443, quando la moglie Polissena è ancora viva. La prima attestazione d’amore è una poesia del 1445, ma la data certa, per diverse ragioni, dell’inizio della loro relazione è il 1446. Sigismondo ha 29 anni, Isotta degli Atti, figlia di un ricco mercante, ha 13 anni, 14 al massimo. Il loro primo figlio muore in fasce nel 1447. In quello stesso 1447 una bolla papale di Niccolò V autorizza Isotta a ricostruire la cappella degli Angeli, quella che nel Tempio malatestiano avrebbe ospitato la sua sontuosa tomba.
Non è sorprendente che Nabokov conoscesse qualcosa di Sigismondo Malatesta. In una intervista che rilasciò ad Alberto Arbasino al Grand Hotel di Roma, durante il suo primo viaggio in Italia con la moglie Véra, – credo nel 1959 o nel 1960 –, poi pubblicata in Sessanta posizioni (1971), Nabokov confessò che per scrivere un libro simile aveva molto faticato per raccogliere tanto materiale, tante informazioni: Ho fatto un lavoro di schedatura tremendo, né più né meno che come quando si fanno dei lavori accademici (dopo tutto, il mio genere di lavoro è sempre molto professorale…).
Per inciso. A fronte delle ripetute e mirabili visite cattoliche al Tempio malatestiano, prima che a qualcuno, venga in mente una processione in riparazione del Nimphet Pride, suscitato dalle fantasie ed esaltazioni presenti nella ristrutturazione dell’ex chiesa di san Francesco, chiariamo subito che tra le miserie morali attribuite dalla Curia all’esecrato Sigismondo – fornicazioni, stupri, adulteri, incesti – non si annovera il misfatto della pedofilia. La consumazione del rapporto con fanciulle era un fatto normale a quel tempo e in quella cultura. Al pari di molte altre culture del mondo e civiltà che si sono succedute nella storia, le relazioni sessuali fra un uomo maturo e una ragazza assai giovane erano un costume diffuso e tutt’altro che peccaminoso. La distinzione tra bambine e donne è considerata la prima mestruazione, il periodo medio della quale va dai 10 ai 16 anni, e la fascia d’età dei 12-14 anni era considerata, in certi tempi e in certi luoghi, quella prevalente per la consumazione del matrimonio. Quando Ginevra d’Este si sposa ha 14 anni, Polissena Sforza ne ha 13. Lo stesso Humbert Humbert provvede a informarci che Dante si innamorò quando Beatrice aveva 9 anni e quando la stessa cosa capitò a Petrarca la sua Laura era una ninfetta dodicenne. Chiudo la semi-parentesi, concludendo che trovo quindi molto sospetto e ipocrita, o alienato o tardo di coscienza, chi, per esempio, accusa Maometto di essere stato un pedofilo. Se non è rozza islamofobia, è comunque l’assoluta incapacità di comprendere la varietà e la ricchezza, si dovrebbe dire l’esuberanza delle culture umane e la straripante polimorfia della sessualità e della possessione erotica.
Ho qui gli appunti del 1907 del ricercatore riminese Luigi Arduini in un elegante opuscoletto intitolato Gli scultori nel tempio malatestiano di Rimini, il cui testo era tratto da una conferenza tenuta tempo prima, in cui affermava lo spirito esclusivamente pagano del monumento che era «un’apoteosi del loro amore, perfino un tempio mutato in santuario della loro passione» dove Isotta era la vera e sola divinità dominatrice. Ho qui le osservazioni del mitografo e storico dell’arte Jean Seznec (1905-1983) che, nelle pagine splendide della sua maggiore opera, La sopravvivenza degli antichi dei pubblicata nel 1940 dal Warburg Institute e più volte riedita e tradotta, dichiara che il trionfo è quello di Sigismondo e «anche l’Amore entra in questa apoteosi: la bella Isotta dorme nella sua superba tomba, ma il suo monogramma e quello di Sigismondo si avvolgono, intrecciandosi l’uno con l’altro, l’arditezza è quasi sacrilega», le divinità pagane «sembrano essere ridotte, in questo luogo sacro, al rango di cortigiani incaricati di scortare due principi e due amanti nell’immortalità» e l’empietà dimora nel «pensiero cristiano assoggettato all’immaginazione antica e ai sentimenti pagani». All’osservatore e lettore esperto sembrerà ovvia l’affermazione di Humbert Humbert: le inclinazioni artistiche non sono caratteri sessuali secondari, come sostengono certi sciamani e scimuniti; è il contrario: il sesso è soltanto l’ancella dell’arte.
Esistono amori illeciti e sbagliati? o solo sbagliati? Sembra di no. Anche Dante nella Divina Commedia pone gli adulteri Paolo e Francesca da Rimini (per restare nel tema: la sventurata tradisce Gianciotto all’età di 15-16 anni) nel secondo cerchio dell’inferno, il primo dei dannati, quello dei lussuriosi, popolato da altri peccatori simili (come Elena, Didone, Cleopatra, Achille, Paride e Tristano). Poiché, agli occhi di Dante, il loro unico peccato era che cercavano l’amore. Non sono quindi sistemati nei cerchi più profondi e più ristretti, quelli più lontani da Dio perché più grave è stato il peccato.
Nella letteratura romantica è l’amore illecito e inaccessibile ad essere celebrato. Nella successiva letteratura più moderna, alcune delle più potenti invocazioni all’amore romantico sono centrate sull’adulterio (Flaubert), l’incesto (Wagner), l’amore omosessuale (Proust) o l’amore per un ninfetta (Nabokov). È questo amore, praticato sotto la licenza di un’autorità morale superiore propria, che trascende i confini religiosi e le convenzioni morali, ad essere esaltato e a provocare l’empatia e l’incanto del lettore.
Scrive Nabokov: Tra i limiti d’età di nove e quattordici anni non mancano le vergini che a certi ammaliati viaggiatori, i quali hanno due volte o parecchie volte il loro numero di anni, rivelano la propria reale natura: una natura non umana, ma di ninfa (vale a dire, demoniaca). Orbene, io propongo di chiamare “ninfette” queste creature eccezionali.
Lolita e ninfetta sono due nomi entrati nel linguaggio comune grazie a Nabokov. Scrisse Pietro Citati il 1° maggio 1994 in la Repubblica in occasione della nuova edizione e traduzione adelphiana (che pure posseggo ma in edizione digitale): «Lolita ha […] un’abbagliante grandezza. Che respiro. Che forza romanzesca. Che potere verbale. Che scintillante alterigia. Che gioco sovrano. […] Non mi ero accorto che possedesse una così straordinaria suggestione mitica». Anche Roberto Calasso in un paio di suoi libri – La letteratura e gli dèi (2001) e La follia che viene dalle Ninfe (2005) – vi ha riconosciuto «l’ultima grandiosa e fiammeggiante celebrazione della Ninfa che è insieme fanciulla pronta alle nozze e polla d’acqua, ma anche messaggera di una forma della conoscenza, forse la più antica, certo la più rischiosa: la possessione».
E allora, sulla natura demoniaca evocata da Nabokov, vi suggerisco di rileggere, ancora una volta, l’accusa di Pio II a Sigismondo: A Rimini ha eretto un nobile tempio a S. Francesco ma l’ha riempito di opere così pagane che non sembra più un tempio cristiano ma di infedeli adoratori di dèmoni; in esso ha eretto una splendida tomba alla sua concubina, apponendovi questa iscrizione alla maniera pagana: Divae Isottae Sacrum.
Si ha l’abitudine di contemplare i daimones, nel nostro Tempio Malatestiano che è stato anche definito erotico, nei putti, eroti, genî, cupidi, amorini, se si vuole anche angioletti (che però hanno la ragion d’essere nell’essere un calco cristiano dei primi), mediatori d’amore e spiriti guardiani che lo affollano e spadroneggiano nell’intero immaginario rinascimentale. Tanta è la fatica per noi uomini di fare «mitologia femminista», ma il Tempio è anche disseminato di ninfe, genî femminili, vergini o giovani donne maritabili, alberganti nelle acque, destatrici d’amore e capaci di infondere l’invasione estatica, apportatrici di fertilità e feconde esse stesse al modo delle acque che scorrono sulla terra. Quell’acqua che continuamente intride la pietra dei bassorilievi di Agostino di Duccio e così essenziale, secondo Adrian Stokes in Stones of Rimini (1934), all’interpretazione della scultura del Tempio che ne fanno un ninfeo lapislazzulo.
Si riconosce nel nostro Tempio la tripudiante leggerezza e quella pioggia di giovinezza, che come l’acqua è sempre vergine e nuova e che denuncia una vena decisamente paganeggiante e iniziatica, allo stesso modo in cui Citati osserva che in Lolita di Nabokov «c’è quella moltitudine di acque correnti, quel brillio e scintillio di luce solare – e poi un fascino segreto, elusivo e mutevole, che possiamo identificare da qualche segno». Come non arrivare, segnati dopo una visita al Tempio d’amore in onore di Isotta, un amore divenuto immortale nella pietra, alle stesse parole conclusive, insieme feroci e pacificate, del romanzo? Penso agli uri e agli angeli, al segreto dei pigmenti duraturi, ai sonetti profetici, al rifugio dell’arte. E questa è la sola immortalità che tu e io possiamo condividere, mia Lolita.
Nell’audace adattamento filmico di Kubrick che rese prima celebre e poi popolare il romanzo di Nabokov, autore anche della sceneggiatura (pur confessando anni dopo che il prodotto finale, girato in Inghilterra, più che un amalgama era stato uno scontro di interpretazioni tra lui e il regista), l’apparizione improvvisa di Lolita immersa in una polla di sole che ci sogguarda da sopra i suoi occhiali scuri come una dea – si è detto – è divenuto l’emblema di una situazione mitica. Il potere iconico di quel gesto, che ha la stessa grazia di rapimento di quello della Venere che sorge dalle acque nel quadro di Botticelli (pittore tra i preferiti di Nabokov), si sarebbe diffuso a macchia d’olio come lo stilema di ciò che è fatale, la forza del divino che si rapporta con noi, sfidandoci, e a cui non ci si può sottrarre. In quegli anni, quel gesto lo vediamo replicato da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany (1961), da Brigitte Bardot, ma anche da Marcello Mastroianni in 8½ (1963) e da Steve McQueen in Bullitt (1968), e trasportato nei nostri giorni da Lana Del Rey.
Lettore, non posso fare a meno di evitare, a questo punto, una nuova parentesi. Non riesco a trascurare una molecola delle mie traiettorie mentali, anche se non è impreveduta, giacché riguarda il futuro del nostro castello malatestiano in procinto di essere ulteriormente devastato in nome di Fellini. Non è che a Londra hanno fatto un museo a Stanley Kubrick in un castello georgiano o in un palazzo storico circondandolo da nuovi bastioni in cemento, dove espongano, che so, gli occhiali di Lolita, la bomba de Il dottor Stranamore, il monolite di 2001: Odissea nello spazio, la bombetta da drugo di Arancia meccanica, l’uniforme di Barry Lindon, il triciclo di Danny di Shining, la maschera di Bill in Eyes Wide Shut. In realtà a Londra hanno praticamente tutto di Kubrick, dagli oggetti di scena ai costumi, dagli script alle foto di scena. L’archivio, donato dalla sua famiglia, si trova alla University of the Arts, dal 2007 a disposizione dei ricercatori che lo hanno fatto diventare un luogo di produzione e redistribuzione della conoscenza della pratica cinematografica del cineasta. E, inoltre, incredibile dictu audituque, i pezzi migliori della collezione sono stati dati in prestito per la Stanley Kubrick Exhibition, una grande mostra che dal 2004 sta girando per tutto il mondo. Ma queste cose vanno dette in un bisbiglio, perché non giungano all’orecchio dell’incallito cronista cantore della Rimini in procinto di diventare cool, del grave banditore del riposizionamento del brand, dei quereli coristi del solido pilastro della civica rinascita culturale prevista dal Piano Strategico. È una figura retorica constatare che a Rimini non esista un’università alla bisogna di Io FF il re del cine (anagramma di Federico Fellini) e come, sul grande cantiere culturale che sta diventando la magnifica e progressiva Rimini, si stia attentamente ascoltando chi sa cos’è la cultura, cioè chi la fa.
Al gesto di Lolita, che era una scena cinematografica già nel romanzo prima ancora di essere immortalato da Kubrick, paragonabile a un artista del Rinascimento italiano, si aggiunge alla luminosa bellezza di lei l’invenzione dei libri posati sulla stuoia. Bisogna cogliere e accarezzare i particolari […], i divini particolari, diceva Nabokov. È un esortazione, per coloro che sono affamati di allegorie e ritrovamenti del significato, a far risaltare coincidenze e analogie anche al di là del loro intreccio storico documentabile. Mettendo in moto la geografia malatestiana vedo dettagli amabili che si irradiano come lampi capricciosi di finissima arte dalla sua trapunta come la medaglia alla diva Isotta, velata, col suo rovescio, il libro di elegie, fusa da Matteo de Pasti nel 1446.
Leggo Nabokov: In noi lo spirito e la carne si erano fusi con una perfezione che deve risultare incomprensibile ai rozzi, prosaici giovanotti di oggi, coi loro cervelli fatti in serie e ho uno choc di divertito riconoscimento nella rutilante diffusione della sigla, composta da una S e una I intrecciate, scolpita su stemmi, frontoni, pilastri e tombe del Tempio Malatestiano di Rimini come un sigillo onnipresente di un eros fisico e metafisico, il monogramma in una stretta indissolubile di due corpi e due anime fuse nella stessa passione, l’intreccio delle due iniziali come la stretta perenne di due mani e di due spiriti per la vita e per la morte in un’isola di tempo incantato.
Verificare un contatto diretto tra Nabokov e l’epoca e il Tempio dei Malatesti è un processo indiziario. Sappiamo che come molti raffinati e colti europei, il padre di Nabokov, facoltoso parlamentare liberale nella Russia zarista, nutriva un profondo interesse per la cultura italiana. Aveva un alto livello di competenza nell’arte rinascimentale italiana e una grande dimestichezza con la musica italiana, specialmente l’opera. Meno noto è che Vladimir senior aveva studiato la lingua italiana, che padroneggiava benissimo. Questo, grazie anche all’ottima conoscenza del latino dopo il ginnasio e la formazione giuridica presso l’Università di San Pietroburgo. Quando trascorse tre mesi nel carcere di Kresty nel 1908, descrisse le sue due ore giornaliere di studio dell’italiano in questo modo: Prendo un libro di grammatica italiana con esercizi e […] comincio ad “ammassare” coniugazioni, verbi irregolari, pronomi, locuzioni, a fare traduzioni nella mia testa. Sappiamo inoltre che conosceva la Francesca da Rimini di Silvio Pellico.
Come suo padre, Nabokov aveva un innato amore per il nostro paese e per la sua lingua. L’Italia, in particolare la sua arte rinascimentale, era molto importante per Nabokov. Condivideva con la moglie Véra il suo amore per i poeti italiani ancor prima di visitare l’Italia. Il suo interesse per la lingua e la cultura italiana si intensificò a cavallo degli Anni ’60, dopo che suo figlio, Dmitri (1934-2012), cantante lirico professionista, si stabilì in ltalia dove Vladimir e Véra lo visitavano spesso da Montreux dove risiedevano. Amava e frequentava l’Italia, soprattutto per la sua arte, e visitò molti dei suoi musei, ma la frequentava anche per i suoi contatti con Mondadori e altri editori italiani. Anche se non conosceva veramente la lingua, la sua finezza nel comprenderla era comunque incredibile.
E ora voglio rivolgere un monito al lettore, affinché non si prenda gioco di me e delle mie elucubrazioni mentali. Giacché le testimonianze sono così difficilmente reperibili, mi sono affaccendato a convincerti coinvolgendoti nell’indagine mediante prove indiziarie, accertamenti, consonanze e coincidenze che potessero impressionarti ma che al momento trascendono le nostre conoscenze, la mia e la tua.
Italo Calvino nel 1959, l’anno in cui Lolita fu pubblicato nella collana Medusa della Arnoldo Mondadori Editore, lo definiva «storia realistica e simbolica insieme». Lo stesso Nabokov, nella ricordata intervista di Arbasino osservava come l’Italia fosse una combinazione di storia, di mito, e di realtà moderna, che quasi mi commuove ogni volta. Aveva prima precisato: «Voi trovate tutti che il vostro paese si sta involgarendo… sento dire. Ma uno straniero, arrivando per la prima volta, vede soprattutto le cose eterne, le più semplici: e queste bastano a convincermi che l’Italia pare il posto più elegante di tutti… Piove, fa brutto tempo: non importa. Noi siamo già incantati».
Nella risposta Nabokov utilizza il qualificativo dell’albergo dove Humbert Humbert possiede per la prima volta Lolita, cui aveva dato un nome sibillino: The Enchanted Hunters, i Cacciatori Incantati.
I Cacciatori Incantati non sono altro che le contemporanee repliche di Atteone. Il cacciatore che, nel corso di una battuta per i boschi, si imbatte in un gruppo di Ninfe intente a bagnarsi in acque limpide con Diana, che ne scopre la nudità. Il cacciatore che, rapito da tanta bellezza diventa preda dei suoi cani, tramutandosi in ciò che cerca e brama e il cui mito è stato analizzato da Giordano Bruno, da Jung e Hillman. Per Bruno significava l’intelletto intento alla caccia della divina sapienza, all’apprension della beltà divina e i suoi veloci levrieri rappresentavano le operazioni dell’intelletto che precede la volontà.
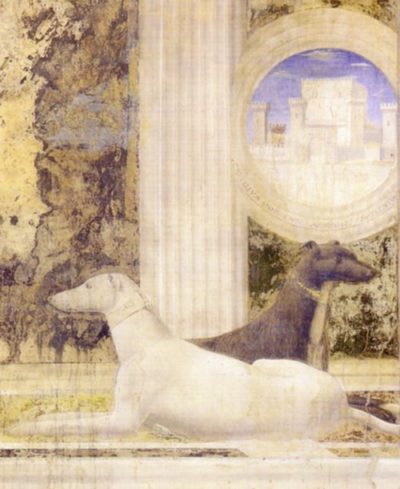
I levrieri di Sigismondo Pandolfo Malatesta, particolare dell’affresco di Piero della Francesca nel Tempio malatestiano di Rimini, 1451
Nel repertorio degli itinerari italiani di Nabokov, tra Stresa, Roma, Milano, Reggio Emilia, Modena e Perugia, con la loro Peugeot 404 noleggiata per seguire le esecuzioni operistiche del figlio, si avvicenderà un altro cacciatore a scoprire se Vladimir e Véra sono per caso scesi anche al Grand Hotel di Rimini, lui ben vestito di grigio o di scuro, lei belle perle, bell’abito nero, bella stola di visone. E a scoprire se abbia visitato il Tempio del più fortunato prototipo rinascimentale di Humbert Humbert.
I giudici considereranno tutto ciò come un esempio della nostra innocente predilezione ad avere come oggetto della nostra ricerca il riaffioramento di miti, figure e simboli nella memoria occidentale, in un campo di caccia che si dischiude ai fruscii e alle risonanze culturali tra Contemporaneo, Rinascimento e Antico.
Questa, dunque, la mia storia. Che, spero, possa essere un po’ anche la tua, Lettore. Quella che racconta era amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista.
Fotografia: Sue Lyon (Dolores Haze detta “Lolita”) nella scena iniziale di “Lolita” di Stanley Kubrick (1962)





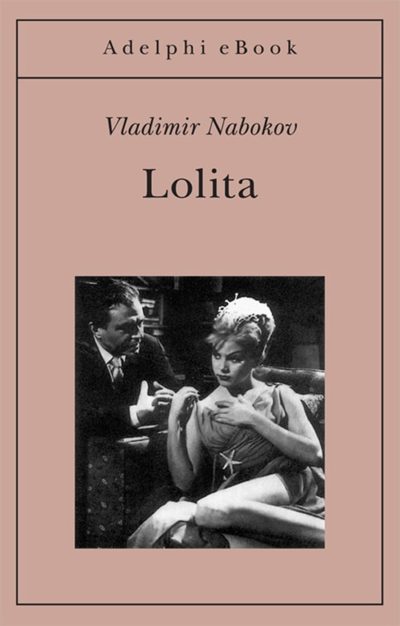





COMMENTI